L’etica del lavoro ben fatto in ingegneria
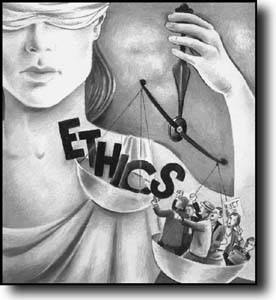 |
Nel cult movie di Ridley Scott, Blade Runner, i «replicanti» di Nexus 6 sono androidi costruiti appositamente per eseguire lavori gravosi senza interrogarsi sugli scopi della loro attività: possiedono una forza sovrumana, ma sono privi di sentimenti e hanno una durata predeterminata. Alcuni di loro si ribellano e vanno in cerca di chi li ha progettati per conoscere il motivo di un’esistenza così limitata. L’epilogo dell’incontro è, com’è noto, drammatico. Solo una macchina, infatti, può limitarsi a funzionare senza sentire il bisogno di una riflessione su di sé e sul proprio lavoro: l’uomo può anche essere costretto a farlo, ma lo subirebbe come una frustrazione intollerabile. Questo mostra come sia una tendenza naturale non soltanto lavorare, ma lavorare bene. Gran parte della narrativa di Primo Levi è dedicata al significato umano del lavoro e all’elogio del lavoro ben fatto. Egli fa dire addirittura a Faussone, il meccanico protagonista del romanzo La chiave a stella: «Ogni lavoro che incomincio è come un primo amore». E in un’intervista con Philip Roth, Levi confidava: «Sono convinto che l’uomo normale è biologicamente costruito per un’attività diretta a un fine, e che l’ozio, o il lavoro senza scopo (come l’Arbeit di Auschwitz) provoca sofferenza e atrofia… Ma ad Auschwitz ho notato spesso un fenomeno curioso: il bisogno del “lavoro ben fatto” è talmente radicato da spingere a far bene anche il lavoro imposto, schiavistico per dignità professionale».
Se il valore etico dell’agire professionale è indiscutibile, viene però da chiedersi: cosa si deve intendere per lavoro ben fatto? In base a quali criteri si può formulare un giudizio sulla correttezza «professionale» dell’esecuzione di un lavoro? Evidentemente, il giudizio degli altri non è sufficiente, anche se potrebbe essere un indizio da non trascurare. Peter Drucker, forse il maggiore esperto di organismi sociali, lo esprime efficacemente con una frase concisa: le imprese debbono fare bene le cose (do well) per poter fare il bene (do good).
Non basta, dunque l’osservanza minimalista di alcune regole, ma occorre portare a compimento un’attività, ossia fare in modo che essa raggiunga il suo scopo, inteso come culmine e non come limite. Compimento non significa, infatti, adeguamento puro e semplice alle regole di base di un’attività, quanto piuttosto realizzazione di qualcosa fino alla sua pienezza. Dunque, perché un lavoro sia un buon lavoro, non basta una corretta esecuzione, ma occorre che la finalità oggettiva dell’opera e lo scopo soggettivo di chi la realizza si armonizzino e siano entrambi buoni. Se, ad esempio, la finalità dell’attività edile è la costruzione di edifici, lo scopo dell’ingegnere non può essere quello di trarne il massimo profitto possibile, quanto piuttosto di realizzare al meglio la costruzione. In questo «meglio» vi è anche la dimensione relazionale, che comprende sia la qualità dei rapporti tra colleghi, dipendenti e dirigenti, sia il beneficio dei destinatari immediati e più in generale della società. Con ragione Fritz Schumacher, in Good Work, ha indicato nel lavoro la più importante terapia contro l’egocentrismo. Secondo l’economista, il buon lavoro deve avere tre caratteristiche: produrre merci e servizi utili, consentire il perfezionamento delle personali doti e abilità, promuovere la collaborazione con gli altri per liberarsi dell’egocentrismo. Una visione unilaterale del lavoro, che trascuri questa triplice dimensione, non perfeziona l'essere umano e non contribuisce a umanizzare la tecnica.
L’etica professionale riguarda pertanto non solo l’agire del singolo, ma anche l’organizzazione dei rapporti, in quanto l’attività –e dunque la responsabilità- di ciascuno non è mai giustapposta alle attività svolte individualmente da altri, ma ne dipende e a sua volta le condiziona in misura più o meno evidente. Il fenomeno attuale cosiddetto delle «many hands», ossia della frammentazione del lavoro in diverse fasi e in distinte figure, pur dando luogo ovviamente a diversi gradi di responsabilità, non può mai significare una diluizione o una rinuncia alla personale capacità di rispondere in prima persona di quanto si è realizzato. Ciò riguarda in modo particolare l’ingegnere che lavora in azienda, ma tocca anche l’ingegnere libero professionista, consulente o docente, il cui lavoro ha sempre una chiara dimensione relazionale.
Per questo motivo, in un’attività che richiede una responsabilità condivisa, buoni professionisti sono coloro che definiscono innanzitutto gli ambiti di competenza e i gradi di responsabilità che spettano a ciascuno, in modo da evitare l’atteggiamento volgarmente definito come scaricabarile o, al contrario, l’invasione di sfere altrui. In ogni caso, l’agire non va confuso con il semplice fare, che priva il soggetto della riflessione sulla qualità etica della sua attività e sugli scopi –più o meno buoni- che persegue.
Günther Anders, chiedendo in una lettera al pilota che aveva bombardato Hiroshima cosa avesse provato nello sganciare la bomba, aveva ricevuto una risposta tragica: «niente, questo è il mio lavoro». È una risposta da homo faber. Ma il soggetto umano è agens faber, in quanto mentre mette in atto delle procedure, è sempre orientato allo scopo di ciò che fa, che comprende anche l’obiettivo del proprio perfezionamento. Nel fare, il fine è il prodotto, nell’agire il fine è il soggetto stesso, che, attraverso il suo fare, migliora o peggiora. Non agire bene significa, dunque, non solo fare il male, ma anche farsi del male. Da qui la necessità di interrogarsi sulla qualità morale delle proprie azioni, alla luce di quella che, tradizionalmente, è stata definita come pratica delle virtù morali. Se invece si riduce il lavoro all’unico segmento che si sta realizzando nell’immediato, senza porsi ulteriori interrogativi, si rischia di funzionare alla stregua di una macchina. Un ruolo così disumano, che persino gli androidi di Blade Runner finiscono per non accettare.
