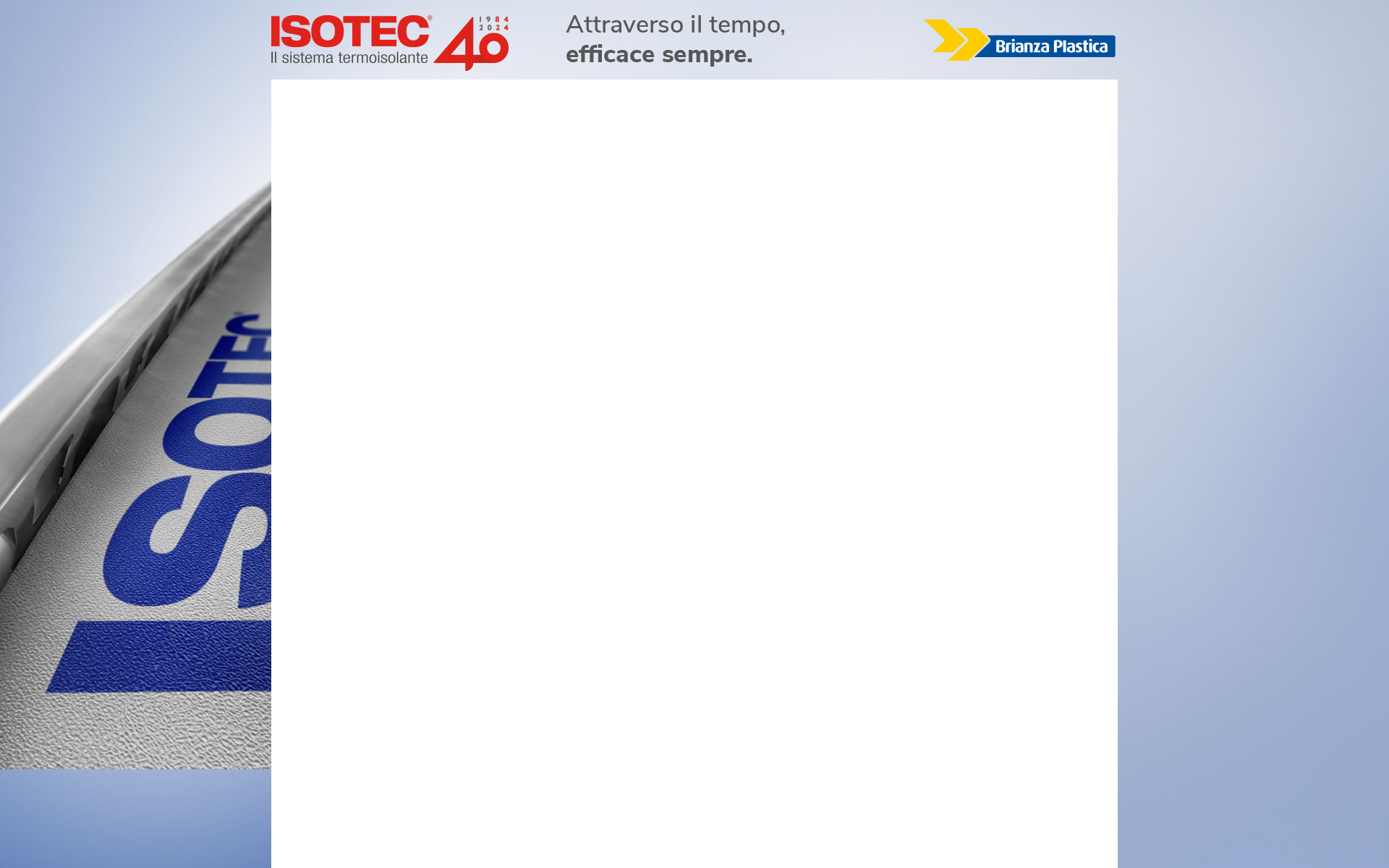Greta Thunber e l'Ing. Franco Cancellieri. Due modi diversi per dire le stesse cose ...
Consulta Ingegneri di Sicilia

TUTTI NOI CONOSCIAMO GRETA THUNBER, LA BAMBINA SVEDESE AL CENTRO DELL'ATTENZIONE MONDIALE IN MERITO ALLA DIFESA PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA IN POCHI SANNO CHE L'ING. FRANCESCO CANCELLIERI DA UNA "VITA" CERCA DI DIRE LE STESSE COSE ...
LO ABBIAMO INVITATO A ILLUSTRARCI GLI STUDI CONDOTTI SUL NOSTRO TERRITORIO E IN PARTICOLAR MODO IN SICILIA ...

Le regioni del Sud Italia sono a rischio desertificazione. In Sicilia tre quarti dei territori sono a rischio. Di questi metà critici. Le conoscenze scientifiche sono sufficienti per passare dall’immobilismo all’azione. Si auspica un’attenzione concreta di quanti sono preposti al governo del territorio.
Introduzione
La desertificazione secondo FAO-UNEP-UNESCO (1977-79) è lariduzione irreversibile della capacità del suolo a produrre risorse e servizi, a cusa di limitazioni climatiche e di attività antropiche.
Processo complesso riconducibile alla interazione di cause predisponenti (morfologia ed orografia, copertura vegetale, etc.), scatenanti (clima e sua variabilità) e acceleranti (processi fisici, chimici e biologici di degrado del suolo, etc.).
Ripercorriamo sinteticamente le tappe più significative della presa di coscienza del fenomeno.
Nel 1951 l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) lancia il Major Project on ScientificResearch on Arid Landscon pubblicazione di un bollettino, di provvedimenti per la concessione di fondi a istituti di ricerca sulle zone aride e l’organizzazione di conferenze varie con pubblicazione di ricerche e rapporti speciali.
Nel 1962 il Major Project fu inglobato nel più generale programma dell’UNESCO sulle risorse naturali.
Nel 1977 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocò a Nairobi (Kenya) una Conferenza Internazionale sulla Desertificazione alla quale parteciparono circa 100 nazioni e organizzazioni internazionali, governative e non. La Conferenza definì la desertificazione Riduzione o distruzione del potenziale biologico del terreno che può condurre a condizioni desertiche. Il Governo italiano ratificò con la legge n. 170 del 4 Giugno 1997 la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e la definizione di desertificazione degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride e sub-umide secche.
Nel 1992 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite(Rio de Janeiro, promosse un Comitato Negoziatore Intergovernativo incaricato di preparare il testo di una Convenzione per Combattere la Desertificazione nei paesi colpiti da grave siccità e/o desertificazione United Nations Convention to CombactDesertification – UNCCD).
Nel 1996 la Convenzione per combattere la Desertificazionevenne ratificata a Parigi ed entrò in vigore il 26 dicembre.
Nel 1997 l’Italia ratificò la Convenzione.
Nel 1999 la Comunità Europea promosse e finanziò studi e ricerche sul tema della desertificazione nel bacino del Mediterraneo (progetti MEDALUS, ARIDUS, EUROMED).
In pochi anni le regioni del Sud Italia scoprono di essere a rischio desertificazione
Grazie soprattutto al progetto DESERTNET - Programma Interreg IIIB-MED-OCC – sono state prodotte diverse mappe del rischio di desertificazione a scala regionale (Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana), elaborate prevalentemente con il protocollo MEDALUS.
La condivisione di metodologia, base dati e scala di rappresentazione ha consentito il confronto ai fini di dello studio delle dinamiche dell’uso del suolo.
Nel volgere di 10 anni vengono date alle stampe varie memorie sulla desertificazionecon annesse cartografie a scala regionale (Barbera et alii, 2005; Bellotti et alii, 2005; Carnemollaet alii, 2001; Ceccarelli et alii, 2006; Ferrara et alii, 2005; Giordano et alii, 2002; Montanarella 2000 e 2001; Motroniet alii, 2003 e 2004; Piccione et alii, 2009).
Il MEDALUS è il protocollo cartografico prevalentemente adottato. Sviluppato attraverso l’omonimo progetto realizzato dall’Unione Europeada Kosmaset alii (1999) consente di individuare le aree sensibili alla desertificazione attraverso l’applicazione di indicatori biofisici e socio-economici.
La metodologia permette una restituzione georiferita della sensibilità alla desertificazione di un territorio distinguendo le aree in critiche, fragili, potenziali e non affette.
Le aree sensibili alla desertificazione sono individuate tramite 4 macroindicatori: suolo, clima, vegetazione e gestione del territorioai quali vieneassegnato un punteggio in relazione alla loro influenza sul processo di desertificazione.
La media geometrica degli indicatori afferenti a ciascuno dei 4 macroindicatorigenera 4Indici di Qualità (QI, Quality Index):
· Suolo (SQI, SoilQuality Index)
· Clima (CQI, ClimateQuality Index)
· Vegetazione (VQI, VegetationQuality Index)
· Gestione del Territorio (MQI, Management Quality Index)
ESA è ottenuto come media geometrica dei 4 Indici di Qualità che lo compongono:
ESA = (SQI · CQI · VQI · MQI)1/4
ed i valori ottenuti sono raggruppati in 4 classi di sensibilità alla desertificazione (dal non affetto al critico).
Il rischio desertificazione in Sicilia
Nel volgere di pochi anni è stata oggetto di varie memorie con cartografie.
Nel 2009 Piccione V., Veneziano V., Malacrinò V. e Campisi S.,adottando rigorosamente il protocollo MEDALUS ai fini della confrontabilità con altri regioni affette dal problema desertificazione, introducono la novità del confronto bi-temporale (prima e seconda metà del XX secolo) dell’andamento del fenomeno desertificazione e un dettaglio informativo di 2.500 mq a terra (50 x 50 m).
Nella prima metà del XX secolo il 74,7% del territorio siciliano presenta un’alta sensibilità alla desertificazione, il 14,8% era mediamente sensibile, il 2,4% potenziale e il 4,5 % non sensibile. Le aree urbane incidono per il 3,7%.
I territori maggiormente sensibili: Stretto di Sicilia.
I territori provinciali più a rischio: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani (Fig.1) .
Nella seconda metà del XXsecolo il 61,1% del territorio siciliano presenta un’alta sensibilità alla desertificazione, il 16,6% è mediamente sensibile, il 3,5% potenziale e il 12,7% non sensibile. Le aree urbane incidono per il 6,1%.
I territori maggiormente sensibili: Stretto di Sicilia e Piana di Catania.
I territori provinciali più a rischio: Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani (Fig.2).
Dal confronto dei due periodi emerge un aumento delle aree non sensibili (+9,3%) e un decremento delle aree ad alta sensibilità (-13,6%).
I territori più a rischio sono al centro di Sicilia, dove dominavano le aridocolture e nello specifico Stretto di Sicilia e Agrigentino.
Le province più a rischio: Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Trapani.
Dei Comuni siciliani 242 regrediscono dalla condizione di massima sensibilità (critico3) per complessivi 16.212 Kmq, 107 subiscono un incremento (8.225 Kmq) e 33 si mantengono stabili.
Iterritori non affetti da rischio desertificazione ricadono prevalentemente nella provincia di Messina dovecondizioni climatiche, vegetazionali e gestionali del territorio presentano caratteristiche di buona qualità (climi umidi e iperumidi, ampie zone boscate e buona parte dei territori sono parchi e riserve).
Nei territori a moderata sensibilità l’equilibrio tra i diversi fattori naturali e/o le attività umane è fragile ed è quindi necessaria un’attenta gestione del territorio.
I territori ad elevata sensibilità si concentrano in provincia di Caltanissetta, Enna e Catania e lungo la fascia costiera agrigentina a causa di fattori pedologici sfavorevoli (colline argillose poco stabili), intensa attività antropica, con conseguente eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, nonché degrado della vegetazione.
Confrontando i due periodiemerge il decremento del rischio desertificazionefrutto del ruolo giocato dall’Indice di Qualità della Vegetazione e di Gestione del Territorio a conferma delle riuscite politiche di conservazione della natura e di reforestazione, unitamente al ritorno alla naturalità di alcuni territori abbandonati.
Nel 2011-12 Piccioneet aliidanno alle stampe la caratterizzazione bi-temporale del rischio desertificazione dei territori comunali della provincia di Siracusaseguito dai comuni delle altre province della Sicilia.Il contributo rappresenta, infatti,il primo di 17 pubblicazioni nel Bollettino dell’AccademiaGioenia di Scienze Naturali che restituiscono la rappresentazione georiferita bi-temporale (prima e seconda metà del XX° secolo) dei 390 territori comunali della regione.
Nel 2013-14 Piccione et alii trattano la tematica delRuolo dei Parchi Regionali Naturali delle Madonie, Nebrodi, Etna e Sicani (Sicilia) nella mitigazione del rischio desertificazione.
Nel 2014 Piccioneet alii, in continuità con la caratterizzazione bi-temporale del rischio desertificazione dei territori comunali siciliani pubblicati nel 2011-12, presenta nella seduta pubblica dell’Accademia Gioenia di Scienze Naturali del 29 novembre 2013 il progetto e i risultati della rappresentazione georiferita bi-temporale (seconda metà del XX secolo – scenario 2030) dei 390 territori comunali della regione (Fig. 3).
Nel 2015Duroet aliimettono a punto un indice (ESPI - Environmentally Sensitive Patch Index) che consente di restituire in una scala 0-100 la sensibilità alla desertificazione di una tessera di territorio (nazione, regione, provincia, comune, bacino idrografico, etc.) restituita da un valore unico superando il limite del MEDALUS. Attraverso l’ESPI gli AA. perseguono l’indicizzazione univoca di un ambito territoriale, con possibilità di produrre graduatorie e ricondurre ad una classificazione e ad un confronto agevole aree e periodi diversi(Fig. 4).
Nel 2016 ad Évora (Portugal)Duro et aliipresentano l’andamento annuale in Sicilia dell’indice di Qualità Climatica(ESPI-CQI), ossia applicato all’Indice di Qualità Climatica.
Dal confronto con l’ESPIemerge che a fronte di un peggioramento climatico (la Fig. 5 evidenzia l’incremento dei valori dal 1931 al 2000) il rischio desertificazione nello stesso periodo si è ridotto grazie ad una felice concomitanza di eventi favorevoli verificatisi nella seconda metà del XX secolo (nascita di parchi e riserve, incremento reforestazioni e recupero di territori alla naturalità).
Per la bibliografiacitata si suggerisce di consultare Google (digitando Autore + desertificazione).
Per il rischio desertificazione in Sicilia digitare Piccione + desertificazione.
In Principali studi sul rischio desertificazione in Sicilia (SIGEA) è riportata una ricca bibliografia (l’articolo può essere scaricato da Google).
Per interrogazione del data base georiferito sulla Land SicilyDegradation, bibliografia e approfondimenti vari si suggerisce di accedere al sito istituzionale dell’IRSSAT (irssat.it).
Cancellieri F.1, Piccione V.2, Veneziano V.3
1 SIGEA – Responsabile Aree Protette ed Ecoregioni, Italia
2 IRSSAT- Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio, Comitato Scientifico, Italia
3 Ph.D. in Biologia ed Ecologia Vegetalein Ambiente Mediterraneo, Catania, Italia