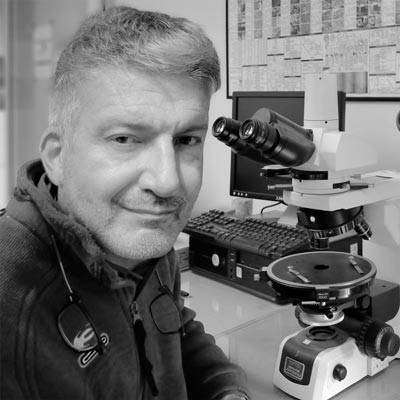Fattori di variabilità nella produzione del calcestruzzo: uno stimolo in più per adottare un modello pienamente prestazionale
La variabilità del calcestruzzo è aumentata con l’introduzione di nuovi materiali e tecniche, rendendo essenziale una gestione rigorosa. Lo studio analizza i fattori influenti e propone modelli prestazionali per garantire affidabilità e sostenibilità.
La variabilità prestazionale del calcestruzzo rappresenta da sempre un importante tema di approfondimento tecnico e normativo. L’interesse è stato principalmente orientato a definire il campo di oscillazione statistica, così da supportare il legislatore nel definire le classi di prestazione caratteristica e i relativi limiti di accettabilità, e il progettista nell’utilizzarle adottando i necessari coefficienti di sicurezza. Con il tempo i fattori di variabilità non si sono ridotti, bensì gradualmente moltiplicati, con la grande diversificazione dei calcestruzzi, dei componenti, delle tecniche formulative, dei sistemi produttivi. E soprattutto con l’avvento dei materiali riciclati, necessari per ridurre l’impatto ambientale delle costruzioni in calcestruzzo. In questo lavoro si analizzano i diversi fattori di variabilità, se ne valuta l’impatto sulla variazione delle proprietà del calcestruzzo e si illustrano i metodi adottati per compensarne o prevenirne l’effetto. Concludendo che il calcestruzzo evoluto e sostenibile sarà affidabile e garantito solo se prescritto e controllato con modelli puramente prestazionali.
Analisi sulla crescente importanza rivestita dai diversi fattori di variabilità sulla produzione del calcestruzzo
L’industria del calcestruzzo si è molto evoluta negli ultimi decenni: nuovi componenti, tecnologie avanzate, software complessi, controllo di processo, certificazioni. Nella Tabella 1 si elencano alcuni degli elementi che, mutati nel tempo, differenziano il contesto attuale da quello della fine del secolo scorso.
Ieri la massima parte del calcestruzzo era un prodotto ‘artigianale’, con prestazioni garantite grazie alla mera ripetizione di formule e di procedure di carico, senza ricorrere ad alcuna attività di ricerca. Si doveva sapere come fare, ma non necessariamente conoscerne il perché. Ignorando, tra l’altro, buona parte dei fattori di variabilità che sono l’oggetto di questa memoria.
È solo grazie ai passi avanti di questi trent’anni che oggi possono essere soddisfatti i requisiti più critici che fanno già parte delle quotidiane prescrizioni: alte resistenze, mantenimento della lavorabilità, assenza di segregazione, ritiro e calore moderati, elementi crescenti di sostenibilità e molto altro ancora.
Se questa evoluzione non è ancora compiuta per tutti, di certo è già obbligatoria per chi oggi si propone per realizzare le costruzioni più critiche e importanti.

In questa memoria cercheremo di mettere in adeguata evidenza alcune conseguenze tecnologiche di questa evoluzione, e in particolare analizzeremo la crescente importanza rivestita dai diversi fattori di fisiologica variabilità che riguardano la produzione di calcestruzzo. Fattori che in passato potevano essere persino ignorati, ma che oggi devono essere presi in seria considerazione e ben gestiti.
Variabilità e prescrizioni
Per l’evoluzione del ready-mix hanno rivestito particolare importanza i requisiti di progetto, che in passato comprendevano ben poche proprietà aggiuntive rispetto alla resistenza. Per giunta, nel recente passato le poche prestazioni richieste erano di solito “concordanti” tra loro: se associate, non mettevano in discussione la fattibilità ma potevano essere sempre rispettate con una formulazione ad abundantiam.
Chi stabilisce i requisiti per il calcestruzzo fa sempre i conti con la variabilità delle prestazioni, ma talvolta non sente il bisogno di approfondirne le diverse cause. Di solito se ne prendono in esame solo gli effetti statistici, allo scopo di neutralizzarli innalzando il requisito stesso. Il parametro principe, la resistenza a compressione, non fa eccezione: è considerato una prestazione inevitabilmente molto variabile e, in linea con questo carattere di imprevedibilità, se ne richiedono valori medi fortemente superiori al minimo richiesto, con un criterio progettuale molto cautelativo, espresso da importanti coefficienti di sicurezza.
Questo approccio, ovviamente, è più che giustificato nel suo intento; tuttavia, se si analizzano a fondo i concreti fattori di variabilità, puntare sempre e soltanto ad una sovra-prestazione può risultare inefficace o impossibile. Specialmente quando le richieste comprendono diverse prestazioni e si pretende che la formulazione sia fissata una volta per tutte.
I modelli di prescrizione e di controllo maturati in Italia nel secolo scorso, infatti, sono spesso fondati sulla convinzione, non sempre espressa ma sempre sottintesa, che un sistema basato sulla fissazione delle ricette e su step di processo immutabili costituisca il miglior antidoto alla variabilità. Quest’ultima, infatti, è attribuita quasi sempre a disfunzioni del processo piuttosto che a variazioni fisiologiche dei componenti o delle condizioni al contorno. Dimostreremo più avanti che i modelli prescrittivi che bloccano la formulazione (confidando nella sovra-prestazione per compensare la variabilità) sono inadeguati di fronte alle nuove necessità progettuali e ambientali.
La Tabella 2 mostra che anche i requisiti più semplici, se discordanti, possono generare problemi di fattibilità e impedire la soluzione ad abundantiam.

L’approccio prescrittivo con fissazione della ricetta rivela una scarsa propensione ad approfondire le vere cause della variabilità, che cercheremo qui di analizzare. Ma soprattutto è in contraddizione con il quadro normativo europeo e italiano, che non fornisce alcun sostegno a chi intenda gestire la variabilità affidandosi soltanto a criteri prescrittivi, come mostra la Tabella 3.

Variabilità e robustezza
Per gli scopi di questa memoria, e secondo una legittima accezione del termine, potremmo definire come “robustezza” la capacità di un prodotto di esprimere prestazioni invarianti anche a fronte della variabilità dei fattori che incidono nel tempo sul suo processo produttivo (Zuo et al., 2021).
Questa accezione non coincide sempre con quella presa in considerazione dalla letteratura tecnica. Buona parte dei lavori che hanno approfondito il concetto di robustezza del calcestruzzo, infatti, hanno come oggetto d’indagine il comportamento reologico degli SCC. In questi casi, per robustezza si intende spesso una sorta di ‘resilienza’ dell’impasto rispetto alle aggressioni a cui è soggetto nelle varie fasi del getto: pompaggio, caduta, scorrimento tra le arma- ture, vibrazione (Kwan et al., 2010).
Oppure, una sua tolleranza rispetto a piccole correzioni nei dosaggi. L’obiettivo è mantenere la fluidità e l’omogeneità dell’impasto, senza segregazione. La robustezza rispetto ai vari fattori sfavorevoli è un’importante proprietà del singolo impasto, riconducibile al concetto di stabilità, e può essere essa stessa oggetto di requi- sito e di prova. Possiamo definirla quindi una robustezza passiva, che non considera modifiche di formulazione a fronte di elementi di variabilità.
La robustezza che qui ci interessa, quella che si oppone ai vari fattori di variabilità nel tempo, è invece necessariamente di tipo attivo perché può esser compensata solo con operazioni mirate di riformulazione. Potremmo chiamarla robustezza dinamica, ed è stata investigata meno frequentemente forse perché risulta più complessa dal punto di vista sperimentale e -a torto- è ritenuta argomento di minore interesse tecno- logico o di esclusiva pertinenza industriale.
I fattori di variabilità
Per poterli ben gestire senza subirli passivamente, dobbiamo conoscere e classificare i diversi fattori che concorrono nel tempo alla variabilità delle prestazioni e delle proprietà dei calcestruzzi
In questa memoria ci concentreremo sui fattori di variabilità “fisiologici”, sostanzialmente inevitabili, cioè quelli non legati a inadempienze dei fornitori, a errori nel processo produttivo, o ancora peggio all’inosservanza di procedure o norme. In altre parole, cercheremo di analizzare la variabilità che affligge anche un sistema compiutamente industriale: ben controllato, rispettoso delle norme, che usa componenti conformi in un processo che assicura la corretta esecuzione delle operazioni.
Potremmo dividere tali fattori di variabilità in tre tipologie: quelli legati ai componenti, quelli connessi con il processo, quelli derivanti dalle condizioni al contorno.
Variabilità fisiologica dei componenti
Aspetti generali
I fattori di variabilità che interessano le caratteristiche dei componenti sono molteplici (Fiorato A. E. 2006). In linea con le premesse, però, prenderemo in considerazione soltanto le oscillazioni fisiologiche tutte comprese nei limiti di accettabilità delle norme, e quindi assolutamente lecite: eventuali défaillance del fornitore rispetto ai valori garantiti con le DoP si configurano come non conformità e sono estranee all’oggetto di indagine di questa memoria.
Dobbiamo poi considerare che i limiti normativi per le proprietà dei componenti non hanno mai avuto come primo obiettivo quello di assicurarne la costanza. Si sono invece consolidati nel tempo, quasi sempre, come ‘vincoli di sicurezza’, veri e propri dispositivi necessari a scongiurare un rischio. Vale a dire, i limiti massimi per il contenuto di sostanze dannose e quelli minimi per le caratteristiche che incidono sull’efficienza prestazionale.
Con queste premesse, il campo di conformità definito dalle norme per le varie proprietà dei componenti risulta in genere piuttosto ampio, talvolta limitato solo in una direzione (con un solo valore di massimo o di minimo da rispettare), e comunque spesso molto più esteso del campo di fisiologica variabilità mostrato di fatto dai componenti stessi.
In ogni caso, entrambi i campi di variabilità (quella consentita e quella effettiva) sono di solito ben più estesi del campo di invarianza prestazionale del calcestruzzo: quel il confine entro il quale dovremmo far restare la proprietà del componente per assicurare nel tempo la costanza delle prestazioni e delle proprietà garantite dal calcestruzzo.
...Continua nel PDF in allegato.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp