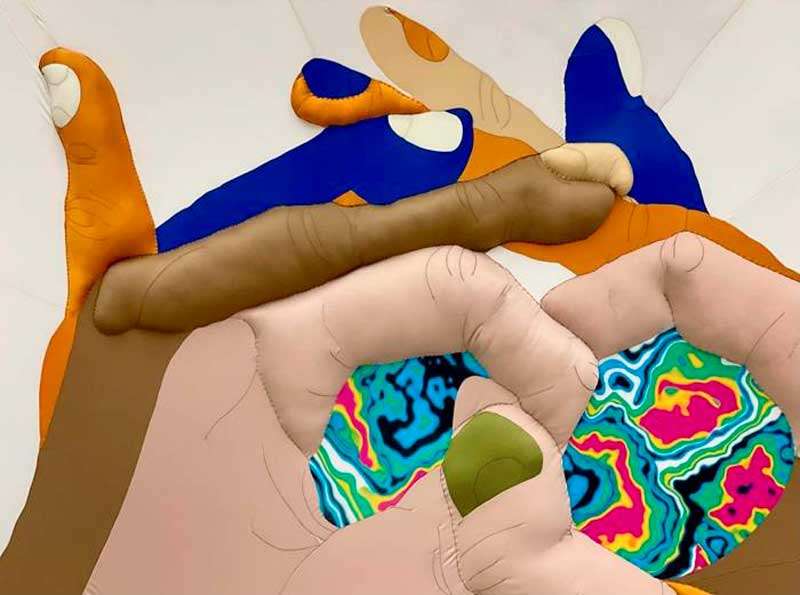Cosa è il potere nell'era dell'intelligenza artificiale
Che cos’è il potere quando il territorio non è più terra ma cloud, algoritmo, data center? Questo articolo esplora il passaggio dal nomos che mette radici al potere che governa lo spazio digitale, attraverso le voci di Schmitt, Heidegger, Han, Bauman e Beck. Una riflessione su controllo, porosità e responsabilità nell’era dell’intelligenza artificiale.
Premessa
Questo articolo è il risultato di una lunga e ostinata riflessione partita dal capitolo «Etica del potere» di Byung-Chul Han nel suo Che cos’è il potere. Pagine complesse, che nascondevano un valore importante ma che faticavo a mettere insieme.
Quelle pagine mi hanno spinto ad addentrarmi in altre opere, tutte citate qui, aprendo un percorso di lettura, annotazione e confronto. Una serie di passaggi, con un andare avanti e indietro anche su testi già archiviati, che pensavo metabolizzati, come La società globale del rischio di Urlich Beck, o La solitudine del cittadino globale di Zygmunt Bauman, o Dove sono di Bruno Latour.
Un percorso con un obiettivo su cui puntare: come cambia il potere nel momento in cui il territorio, il luogo, si dematerializza e diventa virtuale, digitale, algoritmico. Quindi che cosa è il potere nell'era dell'intelligenza artificiale.
La stesura è stata tutt’altro che lineare. Ho passato giorni a scrivere, cancellare, riscrivere; e, per non perdermi nei rimandi incrociati tra autori, ho dialogato con ChatGPT: un compagno virtuale di discussione che mi ha aiutato a sgranare il significato etimologico e semantico di parole-chiave, mettere a fuoco divergenze e consonanze tra i filosofi, condensare idee sparse in un filo coerente. Senza questo compagno di viaggio che spesso si è perso in allucinazioni ma altrettante volte mi ha consentito di cucire i pezzi non sarei riuscito a completare questa fatica narrativa.
Quello che segue è dunque il distillato di approfondimento paziente e confronto continuo fra uomo e macchina.
Spero che queste pagine offrano al lettore lo stesso sostegno critico che hanno dato a me nel cominciare a comprendere come il potere, dai confini della terra fino ai codici del cloud, continui a plasmare i nostri luoghi e la nostra libertà.
Nomos: la legge che mette radici
Questa è stata la parola che ha avviato questa serie di riflessioni: Nómos.
La storia del potere comincia sempre da un gesto molto semplice: prendere un pezzo di terra e dire “questo è nostro”. I Greci chiamavano quel gesto nómos.
Il termine nasce dal verbo nemein – “distribuire, spartire, pascolare” – e porta con sé un’idea concreta: legge e spazio non si separano. Non c’è norma che non afferri un luogo, non c’è luogo che non produca una qualche norma.
Nel libro Il nomos della terra (1950) il giurista tedesco Carl Schmitt è lapidario:
«L’occupazione di terra è l’archetipo di ogni ordine giuridico».
Secondo Schmitt, il primo confine scavato nel suolo divide amici e nemici, interno ed esterno, e genera tutto il resto: proprietà, sovranità, mappe, tribunali.
Il nómos è quindi localizzazione + ordinamento. Se togli la localizzazione la legge diventa un’astrazione senza presa sul reale.
Martin Heidegger: il luogo che accoglie
A distanza di pochi anni, ma da una prospettiva filosofica, Martin Heidegger parla del luogo (Ort) come di un punto che raduna – la hort, la “punta della lancia” dove convergono cielo, terra, divini e mortali.
Diversamente da Schmitt, Heidegger insiste sul lato ospitale del luogo: costruire un ponte, erigere una casa significa lasciare che le cose trovino la loro giusta collocazione, senza ridurle a possesso.
Eppure quel centro attrattivo può trasformarsi in morsa: ciò che accoglie può anche stringere.
Byung-Chul Han: la trazione del centro
Nel saggio Che cosa è il potere il filosofo coreano-tedesco Byung-Chul Han riprende entrambe le intuizioni.
Chiama punto di trazione il luogo che concentra flussi di persone, capitale, informazioni.
- Schmitt mostra la presa di terra come forza fondativa;
- Heidegger svela il luogo che riunisce e dona senso;
Han evidenzia il rischio che quella stessa punta diventi un fulcro di dominio: più tutto confluisce lì, più cresce la possibilità di esclusione.
Nomos ≠ norma astratta
Mettere insieme questi autori ci aiuta a sgombrare un equivoco moderno: la legge non nasce in Parlamento per poi atterrare sul mondo; nasce nel mondo come spartizione, misura, confine, poi diventa articolo di codice.
In pratica, ogni passaggio della presa di terra innesca una catena ben precisa:
- Primo gesto: occupare il suolo. Nel momento in cui qualcuno dice «questo è mio», nasce subito una separazione tra un dentro protetto e un fuori potenzialmente ostile.
- Secondo gesto: tracciare il confine. La linea che delimita lo spazio definisce anche i primi diritti e doveri: chi sta all’interno obbedisce a una certa regola, chi resta fuori ne è escluso o la sfida.
- Terzo gesto: distribuire le risorse. Una volta diviso lo spazio, si stabilisce chi riceve cosa. Così prende forma una gerarchia: chi gestisce la spartizione concentra inevitabilmente potere e ricchezza nelle proprie mani.
In breve, dalla terra alla norma, dalla norma al dominio: il potere cresce ogni volta che un gesto spaziale diventa regola sociale.
Capire il nómos significa quindi capire come lo spazio crea gerarchie prima ancora che lo faccia la scrittura delle leggi. Il nomos è il momento in cui la norma mette radici: non esiste legge senza luogo né luogo senza qualche forma di legge.
Luogo e potere: quando lo spazio diventa comando
Se il nómos è l’attimo in cui la norma afferra un pezzo di terra – l’aratro che incide il solco originario evocato da Carl Schmitt – tutto ciò che segue è la lenta solidificazione di quell’incisione in potere permanente.
Il confine non resta mai un segno inerte: si traduce in infrastruttura di comando.
Prima compaiono le mura e i bastioni, poi i varchi sorvegliati che decidono chi può oltrepassare il “dentro” e chi deve restare nel “fuori”.
Le strade, lungi dal collegare in modo neutrale, dirottano i flussi secondo un disegno politico: il cardo e il decumanus romani assicuravano logistica e controllo militare; i boulevard di Haussmann tagliavano Parigi in direttrici facili da pattugliare, disinnescando le barricate popolari; l’urbanistica barocca, con viali prospettici e piazze scenografiche, esaltava la marcia dei reggimenti e il punto di vista del sovrano.
Lo spazio, osserva Henri Lefebvre, è sempre prodotto da qualcuno per qualcosa: un palinsesto dove si leggono gli obiettivi di chi lo plasma.
Michel Foucault spinge oltre l’analisi: quel palinsesto disciplina i corpi e dirige le condotte. Il cortile della caserma addestra, l’aula scolastica allinea, il corridoio ospedaliero isola; perfino il telaio urbano a maglia regolare della città industriale cronometrava i passi dell’operaio verso il tornio e ne scandiva il ritorno alla casa a ringhiera.
In ognuno di questi esempi il potere sfrutta la geometria per trasformare lo spazio in dispositivo: la linea diventa percorso obbligato, l’incrocio punto di sorveglianza, la piazza teatro di consenso.
Quando la norma mette radici, insomma, germoglia una topografia dell’obbedienza.
Invisibile a uno sguardo distratto, ma determinante quanto un editto scritto, questa topografia guida le vite quotidiane più della legge stessa, perché parla il linguaggio silenzioso delle distanze, dei percorsi obbligati, delle visuali controllate.
Così il solco iniziale del nómos continua a incidere, generazione dopo generazione, la forma concreta delle nostre gerarchie sociali.
Queste considerazioni potrebbero, anzi potranno, portarci a una nuova riflessione: il ruolo dell'architettura, dell'urbanistica, nel definire il futuro della società. In un recente articolo "L’architettura è un atto politico e culturale" evidenziavo come in un’epoca in cui alienazione e sradicamento segnano la quotidianità, l’architettura si rivela molto più che semplice design: è un atto politico, una scelta che determina l’identità collettiva e la partecipazione di chi abita i luoghi.
Progettare significa schierarsi, generare relazioni, trasformare gli spazi in simboli di appartenenza, unendo funzionalità e valori condivisi. In questo modo, si costruisce futuro insieme.
Ma rientra nel percorso di questo approfondimento. Qui l'obiettivo è capire come il potere si sviluppa nel momento in cui il luogo non è più materiale, non è più umano.
L’ipseità che stringe
Ipseità: questo è stato il secondo termine che mi ha colpito e guidato.
Per Derrida e Byung-Chul Han, il centro attrattivo (ipse) può mutare in logica immunitaria:
più risorse attirate → più chiusura per difenderle → più esclusione di ciò che “non torna utile”.
Così nascono città-fortezza, district finanziari blindati, recinzioni “di sicurezza” che definiscono chi appartiene e chi è intercambiabile.
E tornando quindi a Martin Heidegger, alla sua hort, per evitare che la “punta della lancia” diventi lama, servono spazi porosi:
- fasce verdi, parchi, corridoi ecologici;
- piazze pubbliche non recintate e non monetizzate;
- reti infrastrutturali distribuite (trasporti, energia, dati) che riducano la dipendenza da un solo hub.
L’equilibrio fra centralità (che dà coesione) e apertura (che dà libertà) resta la sfida costante di ogni governo del territorio.
Ma parlare di porosità non significa limitarsi all’immagine di un quartiere ben ventilato, di piazze attraversabili o di facciate che lasciano filtrare la luce; vuol dire soprattutto riconoscere che le culture, per vivere, hanno bisogno di fessure attraverso cui circolino idee, persone, lingue. Ogni volta che quelle fessure si sono sigillate, la storia ci ha restituito un’eco di diffidenza e impoverimento; quando invece si sono mantenute aperte, abbiamo assistito a stagioni di straordinaria vitalità.
È sufficiente scorrere la mappa italiana per accorgersene.
Basta guardare al Nord Italia, dove l’incontro con i Longobardi trasformò in profondità paesaggi urbani e istituzioni. Pavia, capitale del regno, divenne un laboratorio nel quale l’Editto di Rotari unì il diritto consuetudinario germanico alla tradizione latina, gettando le basi di un lessico giuridico che sopravvivrà nei secoli. Nei monasteri di Bobbio la severità di Columbano si intrecciò con i moduli architettonici longobardi, creando un ponte fra la spiritualità irlandese e il sapere classico custodito dagli scribi italici. A Cividale del Friuli, il “Tempietto Longobardo” affrescato da maestranze tardo-romane, ma eretto con tecniche nordiche, racconta ancora oggi la libertà con cui stili e iconografie si mescolarono, disegnando una nuova sensibilità religiosa e politica. A Ravenna, i Goti innestarono il gusto nordico sulle tecniche musive tardo-romane: il mausoleo di Teodorico, con le sue cupole e i suoi intarsi, testimonia ancora oggi un’alleanza fra scalpellini ostrogoti, mosaicisti siriaci e architetti imperiali. Più a sud, la Sicilia normanna fuse l’arco ogivale del Nord Europa con la volta a muqarnas del mondo arabo, e l’incontro fra l’Oriente fatimide e l’Occidente vichingo produsse una miscela architettonica capace di parlare, insieme, le lingue del Corano e dei Vangeli. Venezia, crocevia di mercanti e pellegrini, trasformò l’umidità della laguna in un porto spalancato, dove la seta cinese e l’ambra baltica si stringevano la mano davanti alla facciata gotica di Palazzo Ducale.
In tutti questi luoghi la forza non stava nella muraglia che separava, ma nella capacità di metabolizzare ciò che arrivava dall’esterno senza perdere se stessa.
È questo, in fondo, il messaggio che Zygmunt Bauman affida alla sua idea di modernità liquida.
Viviamo in un mondo dove merci, informazioni e persone scorrono più in fretta dei confini e, per quanto l’accelerazione incuta timore, tentare di solidificare ogni cosa equivale a rischiare la frantumazione. Chiudere le frontiere culturali significa sostituire la gestione consapevole del rischio con l’illusione dell’immunità: un rimedio che soffoca esattamente ciò che vorrebbe proteggere. Nelle sue pagine
Bauman ricorda che la storia non registra società collassate per eccesso di scambi, ma conserva invece la memoria di civiltà implose a causa di una sterilizzante chiusura su se stesse; è il destino delle retrotopie, quel sogno di un passato imbalsamato che frantuma il presente invece di sostenerlo.
In tempi di crisi ecologica, di disuguaglianze globali e di migrazioni inarrestabili, mantenere la porosità non è un lusso sentimentale: è l’unico modo di innovare senza amputarsi, di restare resilienti di fronte agli shock e, non da ultimo, di rendere giustizia a chi bussa alle nostre porte spesso perché la nostra stessa prosperità ha contribuito a rendere invivibile la sua terra.
Rinunciare a quelle fessure significherebbe abdicare alla parte migliore della nostra storia.
Le città fortificate sopravvivono sul manuale dei turisti; le civiltà permeabili, invece, continuano a generare vita.
Porosità, dunque, non è soltanto un principio urbanistico: è una scelta di campo, l’antidoto più potente contro la retrotopia, la decisione di accogliere il mutamento come risorsa prima che il mutamento, aggirando ogni muro, si trasformi in tempesta.
Non-luogo digitale: potere senza anticorpi
E veniamo allo spazio di arrivo.
Oggi il potere compie un salto: deterritorializza la propria base materiale, ma non perde la vocazione a concentrarsi:
- La nuova “terra” sono i dati: chi li possiede sorveglia, indirizza, monetizza.
- Il nuovo confine è un pezzo di codice: l’utente lo accetta con un clic, spesso senza leggerlo.
- La nuova punta è il datacenter: fisicamente localissimo, giuridicamente extraterritoriale (norme contrattuali private più forti di quelle statali).
Per millenni abbiamo sviluppato anticorpi che ci hanno consentito di sviluppare contromisure (diplomazia, diritto internazionale, sindacati) all'impermeabilizzazione sociale, alle barriere umane e culturali, allo svilupparsi di un'Ipseità che rende sordi e ciechi.
Nel paesaggio digitale i pericoli non arrivano con lo strepitio di eserciti, ma con il silenzio di stringhe di codice, e contro di essi i vecchi anticorpi non hanno più capacità di azione.
Prendiamo la profilazione di massa: un tempo l’idea che qualcuno seguisse le nostre abitudini passo per passo appariva materia da stato di polizia, e si provava a contenerla con una Carta dei diritti che fissasse il perimetro dell’intimità. Oggi quell’intimità è smembrata in pacchetti di dati che viaggiano fra pubblicitari, data broker, piattaforme social.
I regolamenti esistono – il GDPR europeo, il nascente Data Act – ma somigliano a dighe di sabbia costruite in fretta, mentre la marea cresce più in fretta ancora.
Poi c’è il banishment, l’esilio digitale.
Un tempo chi veniva accusato aveva diritto di difendersi davanti a un giudice; adesso basta un algoritmo opaco per far sparire in un istante il canale di un attivista o la voce di un giornalista.
Le piattaforme hanno creato propri tribunali interni, oversight board che promettono appello e revisione, ma sono camere di compensazione private, dipendenti da coloro che dovrebbero giudicare. In mezzo resta il cittadino, sospeso in un limbo in cui libertà d’espressione e termini di servizio si sovrappongono senza mai coincidere.
Infine il monopolio infrastrutturale.
Davanti ai trust dell’acciaio o del petrolio, gli Stati reagirono con leggi antitrust, costringendo i giganti a dividere linee ferroviarie o oleodotti. Nel dominio del cloud e degli app store il principio è lo stesso, ma l’esecuzione zoppica.
Il Digital Markets Act europeo alza perimetri, impone interoperabilità, minaccia sanzioni. Eppure la concentrazione di server, brevetti e capitali resta vertiginosa, mentre le autorità di concorrenza inseguono col fiato corto innovazioni che si moltiplicano fuori dalla loro giurisdizione.
Così, nel regno dei bit, gli anticorpi tradizionali sopravvivono come fantasmi che cercano un corpo nuovo: troppo esili per contenere la malattia, troppo preziosi per essere accantonati.
La falsa promessa del “non-luogo”
Il web appare ovunque e da nessuna parte, ma dietro c’è sempre un “qualche-luogo”: un cluster di server in Scandinavia, un cavo che attraversa l’Atlantico, una giurisdizione fiscale amichevole.
L’assenza di percezione non equivale a assenza di radicamento – solo rende più difficile rivendicare diritti.
Riscrivere il nomos del cloud: trattare algoritmi e piattaforme come “luoghi giuridici” da rendere trasparenti e contestabili.
Costruire anticorpi culturali: alfabetizzazione critica, diritti digitali, cooperazione transnazionale.
Mantenere la porosità: sia nei territori materiali sia nelle reti virtuali, perché solo luoghi aperti generano libertà invece che dominio.
Il potere, ieri come oggi, nasce dal modo in cui occupiamo lo spazio.
Che sia suolo, pietra o silicio, la sfida rimane: disegnare confini che non diventino muri, centri che non si chiudano, un nomos capace di ospitare anziché escludere.
Ma come farlo?
Conclusioni
Beck e il brivido di un mondo senza parapetti
Ulrich Beck ci mette davanti a uno specchio spietato: viviamo in una società globale del rischio, dove le minacce non arrivano più da eserciti in marcia, ma filtrano tra le maglie invisibili di ciò che abbiamo costruito per confortarci.
Lo ha fatto venticinque anni fa, quando Internet era ancora una strada provinciale, non esisteva Facebook, Youtube, TIk Tok ... l'intelligenza artificiale era oggetto di movie e la pandemia più grande degli ultimi anni era stata la mucca pazza.
Ma già allora è stato capace di guardare oltre l’orizzonte visibile e ci lanciava un segnale inquietante: pensiamo di abitare case solide, ma la scossa che le fa tremare può nascere dall’altra parte del pianeta—un nuovo virus, un default finanziario, un blackout di server. L’aria che respiriamo può portare radiazioni di una centrale che non abbiamo mai visto; i pensieri che formiamo possono essere modulati da un algoritmo scritto in un fuso orario sconosciuto.
Il pericolo, dice Beck, non è più “fuori”, ma “dentro” il nostro stesso progresso.
Ed è qui che il vecchio nómos si incrina: la punta della lancia è diventata una stringa di codice; il confine, una finestra pop-up che ci chiede “Accetti?”; il luogo del potere, un capannone di server dal rumore bianco. La nube digitale ci protegge e, allo stesso tempo, può avvolgerci come nebbia tossica.
Non lasciamo tracce nel terreno, ma lasciamo ogni più piccola traccia di noi in mano a chi controlla la nuvola.
Che fare, come reagire, a questo pericolo nuovo. Ecco cinque passi.
Rendere visibile l’invisibile
Il primo passo è far emergere ciò che ora scorre sotto la soglia del percepito. In un’economia che si alimenta di tracciamenti impercettibili, occorre trasformare i log di sistema in mappe di vento leggibili: archivi pubblici dove cittadini, ricercatori e giornalisti possano seguire il percorso dei propri dati come si seguirebbe la corrente di un fiume.
Gli algoritmi che regolano la visibilità dei contenuti o l’accesso al credito dovrebbero essere sottoposti a audit indipendenti, proprio come gli impianti nucleari vengono ispezionati da enti terzi.
E non basta conoscere le regole logiche: bisogna anche rendicontare l’impronta ecologica e sociale di ogni server‐farm, perché ogni byte richiesto a un’app porta con sé chilowattora bruciati altrove e litri d’acqua evaporati per il raffreddamento.
Inventare una cittadinanza del cloud
La rivoluzione industriale produsse il diritto del lavoro; l’era digitale richiede un diritto dell’abitare virtuale.
Significa riconoscere la portabilità effettiva dei nostri archivi personali, come portiamo con noi il fascicolo sanitario; stabilire un “diritto all’algoritmo spiegabile”, affinché decisioni automatizzate non restino oracoli insondabili; garantire un ricorso terzo contro l’esilio digitale, perché essere cancellati da una piattaforma dominante equivale oggi a perdere voce nello spazio pubblico.
In gioco c’è una nuova forma di cittadinanza, fondata non più soltanto su territorio e passaporto, ma sulla possibilità di circolare – e difendersi – dentro le reti che organizzano la vita quotidiana.
Ricucire terra e rete
Nessun datacenter fluttua nel vuoto. Ogni nuvola informatica poggia su fondamenta terrene fatte di silicio, rame, acqua e chilometri di cavi sottomarini.
Ricucire nómos e phýsis vuol dire riportare alla coscienza collettiva questa materialità occultata: stipulare accordi energetici che vincolino la crescita del cloud a fonti rinnovabili, disegnare criteri di localizzazione che evitino di prosciugare falde o alimentare desertificazioni elettroniche, pretendere etichette ambientali sui servizi digitali come già avviene sugli elettrodomestici. Solo così la tecnica ritorna gesto abitato, non scavo che divora il suolo.
Non cedere al transumanesimo
C’è un confine che tutta l’innovazione, per quanto luminosa, non dovrebbe varcare: quello che custodisce l’intangibile dignità dell’essere creato.
La tradizione biblica parla dell’uomo come immagine e somiglianza di Dio, non come progetto in beta da aggiornare all’infinito. Inseguire la fusione perfetta fra silicio e carne rischia di riecheggiare la torre di Babele, l’antico sogno di una creatura che si sottrae ai propri limiti per salire al cielo con mezzi propri.
La fede ricorda che la fragilità non è un difetto di fabbricazione, ma lo spazio in cui si annida la grazia: la dipendenza dall’altro, il sabato che interrompe il lavoro, il respiro che chiede pausa.
Un progresso che ignora questa dimensione trascendente finirebbe per ridurre la persona a funzione, l’anima a dato, la speranza a protocollo.
Custodire il mistero dell’umano è allora un atto di resistenza spirituale: non nostalgia del passato, ma scelta di restare creature, non creatori, e di abitare la tecnologia senza inginocchiarci davanti ad essa.
Mantenere il legame con il reale
Infine, nessuna innovazione varrà la perdita del contatto diretto con le cose.
La terra sotto le unghie di chi coltiva, la carta ruvida di un libro, il volto non mediato da uno schermo: questi ancoraggi impediscono alla mente di dissolversi in un continuum di simboli.
Educare all’uso consapevole della tecnologia passa per la riabilitazione dei sensi: laboratori in presenza, esperienze di comunità, architetture che invitino a camminare invece di scorrere. Solo restando impastati di reale potremo decidere, con lucidità, che cosa valga la pena digitalizzare e che cosa, invece, debba continuare a vivere fuori dal circuito.
Un appello alla lungimiranza
Beck ci ammonisce: non esistono più catastrofi “locali”. Nel momento in cui tutto è connesso, qualsiasi cedimento si fa nostro—che sia lo scioglimento di un ghiacciaio o la manipolazione di un’elezione. Continuare a disegnare frontiere come se il rischio si fermasse ai valichi è come tentare di arginare il vento con un muro a secco.
E tuttavia, proprio perché la minaccia è globale, anche la possibilità di mutuo soccorso lo è. La rete che concentra il potere può diventare la stessa rete che diffonde conoscenza, allerta, solidarietà. Nomos non è condannato a essere solo controllo: può tornare ad essere cura del luogo—anche di quel luogo intangibile che chiamiamo cloud—se sapremo chiamarlo a responsabilità.
Il potere nasce dal punto che unisce. Ma un punto può essere lama o può essere perno di un ponte.
La scelta—dice Beck—è nostra, e il tempo per decidere scorre alla velocità della luce.
Sta a noi, ora, trasformare la velocità in vigilanza, l’interconnessione in coraggio, la fragilità condivisa in un nuovo patto di coabitazione planetaria
Solo allora il vecchio gesto di tracciare confini potrà cedere il passo a quello, più audace, di disegnare passaggi: dai luoghi che dividono ai luoghi che ospitano, dalle paure che paralizzano alle responsabilità che liberano.
Conclusione finale
Il potere come architettura del possibile
É arrivato il momento di dare una risposta al titolo di questo articolo, che cos’è il potere nell’era dell’intelligenza artificiale.
Nell’era dell’intelligenza artificiale, il potere non è più solo ciò che detiene le risorse o comanda i corpi, ma ciò che progetta, gestisce e governa le condizioni di accesso all’informazione, alla visibilità, all’esistenza stessa nei circuiti digitali
È un potere che non si impone più per interdizione, ma opera per abilitazione selettiva: fa apparire, scomparire, indirizza, silenzia, amplifica. Non costruisce solo muri o varchi materiali, ma codifica i percorsi, definisce gli algoritmi, plasma gli spazi virtuali su cui si giocano reputazione, opportunità, libertà.
Il potere, nell’era dell’IA, è potere di architettura: decide quali connessioni siano possibili, quali accessi siano aperti, quali flussi siano incentivati, quali silenzi siano imposti. È un potere invisibile nella sua infrastruttura, ma pervasivo nei suoi effetti. Non solo governa lo spazio, ma progetta lo spazio stesso del pensabile, del dicibile, del vivibile.
Ed è qui la sfida più urgente: trasformare questo potere architettonico da dispositivo di controllo in cornice di ospitalità. Non spegnere la sua capacità di ordinare, ma orientarla verso una giustizia spaziale, capace di custodire le differenze, mantenere le porosità, difendere il diritto a esistere anche nei margini.
Il potere, nell’era dell’intelligenza artificiale, non potrà più essere semplicemente limitato, frenato, bilanciato: dovrà essere ripensato come responsabilità di cura. Perché quando il territorio è un algoritmo, il nomos è una scelta: possiamo disegnare labirinti o costruire ponti.
Sta a noi decidere se l’intelligenza artificiale sarà strumento di chiusura o leva di apertura, macchina di esclusione o architettura dell’incontro.

AI - Intelligenza Artificiale
Tutto sull’intelligenza artificiale nel settore AEC: progettazione, BIM, cantiere, manutenzione e gestione tecnica. Scopri come l’AI sta cambiando il lavoro dei professionisti delle costruzioni.